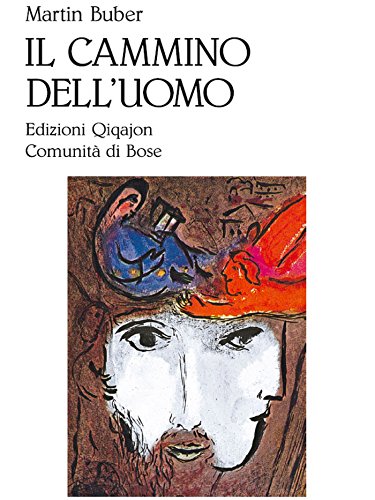Il cammino dell’uomo
Uno scritto che può diventare, per ciascuno di noi, l’occasione per fare il punto sul proprio cammino individuativo.
Hermann Hesse, parlando di questo piccolo libretto dal titolo Il cammino dell’uomo lo definisce: “il libro più bello che io abbia mai letto”.
L’opera si basa su una conferenza tenuta dall’autore al congresso di Woodbrook, a Bentvelt, nel 1947.
Un testo illuminato di spiritualità ebraica, che contiene quelle folgoranti intuizioni che ci possono condurre verso la comprensione di noi stessi, verso la nostra autenticità e unità interiore.
Un libro piccolo capolavoro di grande ispirazione anche per lo psicologo nella sua complessa professione.
Dio dice ad Adamo: “Dove sei?”
Rabbi Shneur Zalaman, il Rav della Russia, era stato incarcerato a Pietroburgo perché calunniato. Il capo delle guardie intuì subito la qualità umana del prigioniero e un giorno, mentre attendeva di comparire davanti al tribunale, entrò nella sua cella ed iniziò a conversare con lui su varie questioni che si era posto leggendo la Scrittura e gli chiese: “Come bisogna interpretare che Dio onnisciente dica ad Adamo ‘Dove sei?’”.
“Credete voi – rispose il Rav – che la scrittura è eterna e abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui?”. “Si, lo credo”, disse “Ebbene – riprese lo Zaddik (che significa “giusto”, il nome dato alle guide delle comunità chassidiche) – in ogni tempo Dio interpella ogni uomo: ‘Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già trascorsi molti: nel frattempo tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo?’. Dio dice, per esempio, “Ecco, sono già quarantasei anni che sei in vita. Dove ti trovi? “.
Nell’udire il numero esatto dei suoi anni, il comandante si controllò a stento, posò la mano sulla spalla del rav ed esclamò: “Bravo!”; ma il cuore gli tremava.
Qual è il significato di questo racconto talmudico? Mentre il comandante cerca di smascherare una pretesa contraddizione nella credenza ebraica che vede in Dio un Essere onnisciente, cercando di presupporre che se è possibile nascondersi allora Dio non è onnisciente, il saggio Rabbi non fornisce un chiarimento alla sua domanda, ma risponde su un altro livello di senso illuminando la situazione perché mira a fargli comprendere: “Adamo sei tu”, perché Dio interpella l’Uomo in ogni tempo e in ogni luogo. Quando il comandante capisce la portata dell’interrogativo posto da Dio, allora vacilla perché comprende di essere interrogato personalmente.
“Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo perché ogni uomo è Adamo della situazione di Adamo. Per sfuggire alla responsabilità della vita che si è vissuta, l’esistenza viene trasformata in un congegno di nascondimento. Proprio nascondendosi così e persistendo sempre in questo nascondimento […] l’uomo scivola sempre più profondamente, nella falsità […] e cercando di nascondersi a Lui, si nasconde a se stesso” (Pag. 21-22)
Il cammino dell’uomo inizia quando Adamo riconosce di essere in trappola e confessa: “Mi sono nascosto”.
Ognuno di noi ha un cammino particolare
Sorge spontanea la domanda: “E qual è il mio cammino?”. È l’interrogativo che il discepolo rivolge al maestro, al santo e al veggente. Ebbene non può esistere una risposta univoca perché è proprio rispondendo correttamente alla domanda “Dove sei?” che ognuno di noi può trovare il suo proprio cammino, che non può mai essere quello di qualcun altro. La santità non è un valore da ricalcare alla lettera, ma da interpretare in modo unico e personale.
“Per quanto infimo possa essere – se paragonato alle opere dei patriarchi – ciò che noi siamo in grado di realizzare, il suo valore risiede comunque nel fatto che siamo noi a realizzarlo nel modo a noi proprio e con le nostre forze[…] Con ogni uomo viene al mondo qualcosa di nuovo che non è mai esistito, qualcosa di primo e unico […] Ciascuno è tenuto a sviluppare e a dar corpo proprio a questa unicità e irripetibilità, non invece a rifare ancora una volta ciò che un altro – fosse pure la persona più grande – ha già realizzato” (Pag. 26-27).
Questo insegnamento che si basa sul fatto che “tutti gli uomini sono ineguali per natura e pertanto non bisogna tentare di renderli uguali” è al centro di tutte le tradizioni spirituali. “Tutti gli uomini hanno accesso a Dio, ma ciascuno ha un accesso diverso. È infatti la diversità degli uomini, la differenziazione delle loro qualità e delle loro tendenze che costituisce la più grande risorsa del genere umano. L’universalità di Dio consiste nella molteplicità dei cammini che conducono a Lui, ciascuno dei quali è riservato a un uomo” (Pag. 28).
Dio non dice: “Questo cammino conduce fino a me, mentre quell’altro no”; dice invece: “Tutto quello che fai può essere un cammino verso di me, a condizione che tu lo faccia in modo tale che ti conduca fino a me”. In questo senso, guardare un altro per cercare di imitarlo, può condurre fuori strada, in errore. Il Baal-Shem (fondatore del cassidismo) dice: “Ognuno si comporti conformemente al grado che è il suo. Se non avviene così, e uno si impadronisce del grado del compagno e si lascia sfuggire il proprio, non realizzerà ne l’uno ne l’altro […] In ognuno di noi c’è qualcosa di prezioso che non c’è in nessun altro” (Pag. 29).
Il compito più importante è allora cogliere la nostra esigenza o inclinazione più profonda, quel desiderio fondamentale che muove l’aspetto più intimo del nostro essere. “Qualsiasi atto naturale, se santificato, conduce a Dio, e la natura ha bisogno dell’uomo perché compia in lei ciò che nessun angelo può compiere: santificarla” (Pag. 32).
Questo è il cammino dell’uomo, un percorso di “santificazione”.
Dal conflitto all’unità
“Un chassid del Veggente di Lublino decise un giorno di digiunare da un sabato all’altro. Ma il pomeriggio del venerdì fu assalito da una sete così atroce che credette di morire. Individuata una fontana, vi si avvicinò per bere. Ma subito si ricredette, pensando che per un’oretta che doveva ancora sopportare avrebbe distrutto l’intera fatica di quella settimana. Non bevve e si allontanò dalla fontana. Se ne andò fiero di aver saputo trionfare su quella difficile prova; ma, resosene conto disse a se stesso: ‘È meglio che vada e beva, piuttosto che acconsentire a che il mio cuore soccomba all’orgoglio’. Tornò indietro, si riavvicinò alla fontana e stava già per chinarsi ad attingere acqua, quando si accorse che la sete era scomparsa. Alla sera, per l’apertura del sabato, arrivò dal suo maestro. ‘Un rammendo!, esclamò lo zaddik appena lo vide sulla soglia”.
Il discepolo zelante si impegna al massimo, combatte con tutte le sue forze per realizzare una difficile ascesi. “Come è possibile essere rimproverati per una simile lotta interiore? Non significa esigere troppo dall’uomo?” Il Veggente è così duro perché lo vuole mettere in guardia su una cosa che gli impedirà di raggiungere il grado più elevato a cui lui aspira, di conseguire il suo progetto: “oggetto del biasimo è il fatto di avanzare e poi indietreggiare; è l’andirivieni, il procedere a zigzag dell’azione che è opinabile.
L’opposto del “rammendo” è il lavoro fatto di getto. Come realizzare un lavoro in un sol getto? Non in altro modo che con un’anima “unificata”.
Nella interpretazione proposta da Büber di questa storiella tradizionale chassidica, il maestro colpisce nel discepolo la mancanza di unità che aveva dimostrato, la sua tendenza ad oscillare tra decisioni diverse e opposte che rendevano la sua azione un “rammendo”, un rattoppo che toglie unità e bellezza al vestito, sintomo di una divisione interiore.
Il comportamento del discepolo rappresenta la condizione di divisione e dispersione interiore in cui spesso ci si trova a vivere, la condizione molteplice, complicata e spesso contraddittoria della nostra interiorità.
L’azione che ne deriva non può che essere caratterizzata da una serie di inciampi, impedimenti e tentazioni. Il discepolo “cosa può fare se non, appunto, ogni volta, nel corso dell’azione, ‘riprendersi’ – come si usa dire -, cioè raccogliere la propria anima sfilacciata in tutte le direzioni, concentrarla e indirizzarla sempre nuovamente verso la meta […]” (Pag. 36).
L’insegnamento contenuto nella saggezza della tradizione ebraica ci fa capire che certamente l’uomo di ogni tempo ha una natura molteplice, complicata, conflittuale e contraddittoria ma “è in grado di agire su di essa per trasformarla, può legare le une e le altre forze in conflitto e fondere insieme gli elementi che tendono a separarsi, è in grado di unificarla.
Questa unificazione deve prodursi prima che l’uomo intraprenda un’opera eccezionale. Solo con un’anima unificata sarà in grado di compierla in modo tale che il risultato sia non un rammendo ma un lavoro d’un sol getto” (Pag. 37).
Il Veggente, con la sua durezza, rimprovera il discepolo di “aver corso l’azzardo con un’anima non unificata”. E Büber sottolinea il fatto che non è l’ascesi a provocare l’unificazione. La rinuncia, il digiuno, l’ascesi sono pratiche che possono solamente concentrare le forze verso il conseguimento della meta, del risultato.
Cosa provoca allora l’unificazione interiore? Il nostro io a patto che si possa postulare in noi un centro direttivo e di governo della persona? Come fa l’io a governare se è esso stesso spesso coinvolto nel conflitto? L’unificazione avviene ad opera del nucleo più intimo della nostra anima. È “la forza divina che giace nelle sue profondità” a fondere le forze, i vettori e la natura delle nostre parti in conflitto.
“C’è tuttavia un aspetto che bisogna tenere ben presente: nessuna unificazione dell’anima è definitiva. Come l’anima più unitaria per nascita è pur tuttavia assalita a volte da difficoltà interiori, così anche l’anima più accanita nella lotta per la propria unità non può mai raggiungerla pienamente” (Pag. 39).
“Però ogni opera che compio con un’anima unificata agisce di rimando sulla mia anima, agisce nel senso di una nuova e più elevata unificazione; ognuna di queste opere mi conduce, anche se con diverse deviazioni, a un’entità più costante di quella più precedente.
Alla fine si giunge così a un punto a cui ci si può affidare alla propria anima perché il suo grado di unità è ormai così elevato che essa supera la contraddizione come per gioco. Anche allora, naturalmente, è opportuno restare vigilanti, ma è una vigilanza serena” (Pag. 38).
Un aneddoto racconta che un giorno Rabbi Nahum colse gli studenti che giocavano a dama che quando lo video smisero di giocare: “Vi dirò io le leggi del gioco della dama. Primo: non è permesso fare due passi alla volta. Secondo: è permesso andare solo avanti. Terzo: quando si è arrivati in alto si può andare dove si vuole”.
Il termine “Anima” per Büber significa “uomo intero” nel quale corpo e spirito sono unificati. “L’anima è realmente unificata solo a condizione che tutte le forze, tutte le membra del corpo lo siano anch’esse […] Quando l’uomo diventa una simile unità di corpo e di spirito, allora la sua opera è opera d’un sol getto” (Pap. 40).
Cominciare da se stessi
Anche l’insegnamento chassidico, come in fondo tutti gli insegnamenti delle tradizioni spirituali, mette in luce come il confitto tra gli uomini vada ricondotto al di la dei motivi esteriori e coscienti delle loro dispute, dei processi oggettivi che stanno alla base di questi conflitti.
Tale insegnamento “ha di mira l’uomo intero” e si fonda sulla consapevolezza che “solo la comprensione della totalità in quanto tale può comportare una trasformazione reale, una vera guarigione, innanzitutto dell’individuo e poi del rapporto tra questi e i suoi simili. Nessun fenomeno dell’anima va preso isolatamente, messo al centro dell’esame.
È invece indispensabile considerare tutti i punti, e non in modo separato, ma proprio nella loro connessione vitale […] Bisogna che l’uomo si renda conto innanzitutto lui stesso che le situazioni conflittuali che l’oppongono agli altri sono conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima, e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi così rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato, pacificato, e allacciare con loro relazioni nuove, trasformate” (Pag. 44).
“Cominciare da se stessi: ecco l’unica cosa che conta […] Il punto di Archimede a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me stesso. Se invece pongo due punti di appoggio, uno qui nella mia anima e l’altro là, nell’anima del mio simile in conflitto con me, quell’unico punto sul quale mi si era aperta una prospettiva, mi sfugge immediatamente” (Pag. 45).
“Ogni conflitto tra me e i miei simili deriva dal fatto che non dico quello che penso e non faccio quello che dico”. Si tratta del conflitto di tre aspetti nell’uomo: “il pensiero, la parole e l’azione”. Siamo per natura esseri contradditori cercano continuamente di nascondersi a se stessi proiettando le proprie incongruenze interiori sugli altri. Per uscirne e diventare uomini autentici, unificati, è importante volere la svolta e capirne la portata.
“Ma per essere all’altezza di questo grande compito, l’uomo deve innanzitutto, al di la della farragine di cose senza valore ce ingombra la sua vita, raggiungere il suo sé, deve trovare se stesso, non l’io ovvio dell’individuo egocentrico, ma il sé profondo della persona che vive con il mondo […] (Pag. 47).
Non preoccuparsi di sé
A che scopo tornare a sé stessi? Qual è il fine dell’unificazione interiore? Perché portare ad unità il mio essere? Ebbene la risposta è: “Non per me!”. Lo scopo dell’abbracciare un cammino di evoluzione e integrazione personale se è vero che deve cominicare da se stessi, non deve finire con se stessi; “prendersi non come meta, ma solamente come punto di partenza; conoscersi, ma non preoccuparsi di sé” (Pag. 50).
Quando Rabbi Hajim di Zans ebbe unito in matrimonio suo figlio con la figlia di Rabbi Eleazaro, il giorno dopo le nozze si recò dal padre della sposa e disse: “O suocero, eccoci parenti, ormai siamo così intimi che vi posso dire ciò che mi tormenta il cuore. Vedete ho barba e capelli bianchi e non ho ancora fatto penitenza”. “Ah, suocero – gli rispose Rabbi Eleazaro – voi pensate solo a voi stesso. Dimenticatevi di voi e pensate al mondo!”.
Il racconto ci presenta uno zaddik, un uomo pio e caritatevole che, giunto alla vecchiaia, confessa di non aver compiuto l’autentico ritorno il quale si sente dire dal suocero “Invece di tormentarti incessantemente per le colpe commesse, devi applicare la forza d’animo utilizzata per questa autoaccusa all’azione che sei chiamato a esercitare sul mondo. Non di te stesso, ma del mondo ti devi preoccupare!” (Pag. 51).
Nella concezione ebraica del cammino dell’uomo il ritorno ha un significato che va ben al di la della penitenza. Il ritorno è il cammino che va dal caos in cui l’uomo si è smarrito verso il bene, “attraverso una virata di tutto il suo essere, un cammino verso Dio, cioè il cammino verso l’adempimento del compito particolare al quale Dio ha destinato proprio lui, quest’uomo particolare” (Pag. 52).
Il pentimento è solo l’impulso “che fa scattare questa virata attiva”, ma non un esercizio di auto fustigazione che rende lo spirito rozzo e il cuore duro. “Hai agito male? Contrapponi al male un’azione buona” e quindi “occupati del mondo”afferma il rabbino.
“Bisogna dimenticare se stessi e pensare al mondo. Il fatto di fissare come scopo la salvezza della propria anima è considerato qui solo come la forma più sublime di egocentrismo” (Pag. 54).
Nell’ebraismo ogni anima umana è al servizio della creazione per cui non è fissato un fine all’interno di sé stessa, nella propria salvezza individuale. Se è vero che ognuno di noi deve giungere alla sua pienezza, salvezza e purificazione questo cammino non è mai a vantaggio di sé stessi, della propria felicità terrena, ma ha senso lo all’interno della creazione, cioè del progetto di Dio.
Una volta Rabbi Mendel di Kozk, disse alla comunità riunita: “Cosa chiedo a ciascuno di voi? Tre cose soltanto: non sbirciare fuori di sé, non sbirciare dentro agli altri, non pensare a sé stessi”.
“Il che significa: primo, che ciascuno deve custodire e santificare la propria anima nel modo e nel luogo a lui propri, senza invidiare il modo e il luogo degli altri; secondo, che ciascuno deve rispettare il mistero dell’anima del suo simile e astenersi dal penetrarvi con un’indiscrezione impudente e dall’utilizzarlo per i propri fini; terzo, che ciascuno deve, nella vita con se stesso e nella vita con il mondo, guardarsi dal prendere se stesso come fine” (Pag. 56).
Il tesoro è dove ci si trova
Rabbi Eisik, dopo anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, ricevette in sogno l’ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripete per la terza volta, Eisik si mise in cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin li dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò a ridere: “E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, ah! Stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa! Eisik figlio di Jekel, ma scherzi? Eisik torno a casa sua e dissotterrò il tesoro.
Questa storia è antica ed è presente in tutte le tradizioni popolari e il suo significato è che c’è qualcosa che tu non puoi trovare in alcuna parte del mondo, eppure la puoi trovare esattamente dove ti trovi.
“C’è una cosa che si può trovare in un unico luogo al mondo, è un grande tesoro, lo si può chiamare il compimento dell’esistenza. E il luogo in cui si trova questo tesoro è il luogo in cui si trova” (Pag. 50).
Siamo sempre mossi a cercare altrove, ovunque tranne che la dove siamo, la dove siamo stati posti, “ma è proprio la e da nessun’altra parte, che si trova il tesoro. Nell’ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi è toccata in sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana mi richiede. “È sotto la stufa di casa nostra che è sepolto il nostro tesoro”.
Un giorno Rabbi Mendel di Kozk chiese ai suoi ospiti a bruciapelo “Dove abita Dio?”. Quelli risero di lui ma il Rabbi diede lui stesso la risposta: “Dio abita dove lo si lascia entrare”.
Ecco il mistero della nostra esistenza, l’opportunità sovraumana del genere umano: “Dio vuole entrare nel mondo che è suo, ma vuole farlo attraverso l’uomo”.
Martin Büber, Il cammino dell’uomo, Qiqajon, Comunità di Bose, 1990